«Una musica si può ascoltare, un quadro si può guardare, ma solo un piatto si può mangiare. Cibarsi è un atto introspettivo: ci nutriamo di ciò che ci corrisponde. Mangiare è perciò un’azione rivelatrice: un semplice carrello della spesa, in fondo, spiega molte cose della persona che si ha di fronte». Nasce da qui il profondo rapporto che intercorre tra arte e cibo: un connubio dalle radici solide, ancorato all’esigenza atavica dell’essere umano di esprimere concetti capaci di stimolare i ricettori dei propri messaggi; visivi, uditivi, tattili o gustativi che siano. Almeno secondo il pensiero di Pietro Leemann del Joia di Milano, che ha recentemente accettato di partecipare all’inaugurazione di un evento teso proprio a sondare l’intima relazione tra arte ed enogastronomia: dedicato alla serie No Seconds del noezelandese Henry Hargreaves, che ha fotografato l’ultimo pasto di alcuni condannati a morte americani, la mostra, in programma al veneziano Museo della follia, è un progetto articolato (vedi box a fianco), capace di raccogliere attorno alla propria idea centrale numerosi giornalisti e food blogger, nonché alcuni rinomati chef europei, tra cui lo stesso Leemann, da sempre convinto sostenitore del potere assertivo del cibo.
«A differenza delle altre arti, però», riprende il titolare del primo ristorante vegetariano del Vecchio continente a ricevere una stella Michelin, «la cucina non può che esprimere concetti costruttivi. Una ricetta contenente esclusivamente un messaggio di violenza o di sofferenza non solo rischia di far star male i commensali, ma non sarebbe neppure economicamente sostenibile: nessuno comprerebbe infatti un piatto celebrante la morte e la paura. Nel passato ci hanno provato alcuni futuristi, è vero, ma la loro opera si inseriva in un contesto differente: quelle creazioni non si potevano mangiare, mentre la vera arte culinaria non può mai prescindere dalla propria commestibilità».
In realtà, per Leemann, nessuna forma artistica dovrebbe mai rinunciare a lanciare un messaggio positivo: «Anche quando si realizza un’opera di denuncia, occorre sempre provare a dare una soluzione, una via di uscita. Autori come Albert Camus e Jean-Paul Sartre, per esempio, non riescono a piacermi fino in fondo, proprio perché indulgono in una visione pessimista e priva di prospettive. A mio avviso, invece, l’arte ha senso solamente quando è in grado di aiutare le persone a evolversi e a stare meglio: perché se un individuo guarda, legge o ascolta solo rappresentazioni di violenza, ovvero si ciba in modo pessimo e aggressivo, finirà inevitabilmente per diventare quello che fa. Attraverso la cucina vegetariana io miro perciò a celebrare la vita, la libertà di scelta dell’individuo e il contatto con il divino. Scopo dell’esistenza, infatti, è proprio quello di migliorarsi: è l’evoluzione che ci rende veramente felici; un bel paesaggio, un buon libro e una cucina virtuosa ci aiutano tutti a realizzare il medesimo obiettivo».
La contraddizione tra il pensiero positivo di Leemann e la sua partecipazione a No seconds è così solo apparente: «Quando mi è stata presentata la mostra, ho subito pensato che l’argomento, trattando della morte, fosse alquanto distante dal mio lavoro. La mia paura, in particolare, era che si strumentalizzasse un argomento tanto delicato per una mera operazione commerciale. In realtà ho presto scoperto che lo scopo degli organizzatori era ben diverso, legato alla riflessione sulla pena capitale e sui modi in cui ognuno di noi ritiene di poter affrontare la propria fine: una tematica, quest’ultima, che è invece sempre presente in me. Da qui l’idea di proporre al vernissage una serie di ricette, in grado di condurre i visitatori in una sorta di percorso iniziatico di riflessione e rinascita. Uno dei miei piatti, in particolare, è stato servito in un ambiente completamente avvolto di fumo, per poi essere consumato sulla terrazza prospiciente la laguna: quasi a simboleggiare il passaggio dal buio alla luce».
È insomma un approccio alla cucina fortemente caratterizzante quello dello chef del Joia: un punto di vista forte, che non può non sollevare domande sul rapporto tra un’offerta tanto personalizzata e alcune tipologie di avventori. «In realtà», risponde subito Leemann, «sono convinto che ogni cliente scelga il ristorante più rispondente alla propria personalità: io sono sempre felice dei miei commensali, perché viaggiamo sulla stessa lunghezza d’onda, stimolandoci reciprocamente». Questo equilibrio ideale, tuttavia, si può raggiungere solo a patto di una sincerità senza compromessi: «L’ho sperimentato io stesso sulla mia pelle: quando aprii il Joia, ormai più di 25 anni fa, all’inizio cercai di mediare il mio pensiero, con quelle che pensavo fossero le esigenze del cliente generico; il risultato fu un’offerta timorosa, contaminata di paure, che mi impediva di cucinare ciò che ritenevo fosse giusto. La mia maturità arrivò solo quando capii esattamente quello che volevo e i miei piatti divennero al contempo buoni e autentici».
Ma qual è il momento in cui è concesso a un professionista della cucina di cominciare a dare libero sfogo alla propria creatività e personalità? «Prima di tutto bisogna imparare a lavorare», conclude Leemann rivolgendosi soprattutto ai più giovani. «Altrimenti è come provare a tratteggiare un volto astratto senza conoscere le basi del disegno. Poi occorre mantenere un’attitudine umile vero la conoscenza, provando sempre a rimanere coerenti con se stessi. Infine, è importante ricercare ovunque la semplicità, rifuggendo dalle soluzioni complesse e artefatte, senza però rinunciare, al contempo, alla sperimentazione e allo sforzo continuo per migliorarsi».
L’evento veneziano dedicato a No Seconds
events.artmovie.IT; contest.artmovie.IT
Dalla seria fotografica No Seconds, dedicata all’ultimo pasto di alcuni condannati a morte americani, prende le mosse la prima personale, mai organizzata al di fuori degli Stati Uniti, riservata al lavoro sul rapporto tra cibo e cultura di massa del fotografo neozelandese, ma newyorkese d’adozione, Henry Hargreaves: un viaggio nell’anima alla scoperta di quel profumo, quell’aroma, quel piatto perduto nell’io più profondo, eppure così caro da volerlo considerare il Piatto dell’ultimo desiderio. In programma fino al 14 novembre presso il Museo della follia di Venezia, la mostra Henry Hargreaves, No seconds, comfort food e fotografia, ha coinvolto, per il suo vernissage, tre chef d’autore come Pietro Leemann, Andy Luotto e Pierchristian Zanotto, che hanno contribuito alla realizzazione di un percorso emozionale, tutto dedicato all’ancestrale capacità evocativa del cibo. In parallelo con l’esposizione, il progetto prevede anche un movie-contest dal titolo «L’ultimo desiderio», il cui obiettivo è quello di spingere gli utenti online a raccontare, scavando nella propria memoria, il proprio piatto «ultimo desiderio».

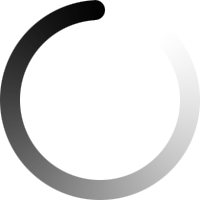
Comments are closed