Ne abbiamo parlato spesso, negli ultimi mesi, anche sulle pagine del nostro magazine digitale ed è uno degli argomenti dei quali responsabili HR, general manager, capi reparto più discutono anche durante i nostri eventi di TFP Summit: la centralità degli investimenti sul benessere dei collaboratori come leva strategica per attrarre e trattenere personale. E se è vero che le aziende, anche nel comparto del turismo, stanno sviluppando una maggior sensibilità al tema e sempre più spesso allocano fondi per progetti dedicati al cosiddetto “corporate wellebeing”, rimane ancora ampio il divario tra ciò che riescono a offrire e ciò che i lavoratori realmente vorrebbero. Una questione più strategica, a ben vedere, che di mero budget.
A rilevarlo non solo solamente le analisi “sul campo” di chi si occupa di recruiting e gestione del personale, e conosce bene la situazione, ma anche i numeri. Ha provato a misurarli, recentemente, una ricerca dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, condotta in collaborazione con JOINTLY, B Corp italiana specializzata in corporate wellbeing, intitolata non a caso “Il corporate wellbeing mismatch: come rispondere in maniera efficace alle aspettative di benessere dei lavoratori in azienda”. Un’analisi trasversale a tutti i settori economici, ma che contiene spunti utili anche per il settore del turismo e dell’ospitalità, che sta vivendo una profonda disaffezione da parte soprattutto dei professionisti più giovani. Vediamo, dunque, qual è la fotografia scattata da questa ricerca in questo approfondimento dall’ultimo numero del nostro magazine digitale, sfogliabile per intero a questo LINK.
Perché investire in corporate wellbeing
Innanzitutto, lo scenario generale: oggi in Italia più della metà (64%) delle aziende offre servizi a supporto del benessere psico- fisico e relazionale dei propri collaboratori, eppure meno di un lavoratore su dieci sta davvero bene sul posto di lavoro e solo uno su quattro ritiene che la propria azienda si occupi concretamente del suo benessere. Ciò accade perché, benché le imprese italiane stiano investendo in corporate wellbeing, con una spesa media di 1850 euro per dipendente, solo un decimo del budget è allocato su benefit che assolvono ai bisogni di benessere, conciliazione vita lavorativa-vita privata e sviluppo professionale, risultando spesso inefficaci.
Star bene anche al lavoro – rimarca la ricerca – è una vera e propria priorità: solo nell’ultimo anno 1 lavoratore su 3 ha cambiato o ha intenzione di cambiare proprio a causa della mancanza di benessere, con un picco tra i GenZers (39%). Le aziende sono ormai consapevoli dell’importanza di far star bene i propri collaboratori per non perderli, e stanno cercando soluzioni. Ma lo studio mostra come investano ancora poco nelle iniziative legate principalmente al benessere e all’engagement, prediligendo invece i benefit di welfare tradizionale. Si limitano, cioè, alle misure più semplici da erogare e apparentemente più efficaci e immediate.
Come investono le aziende
Il 90% del budget che complessivamente le imprese stanziano per tutte le iniziative è, infatti, ancora allocato su benefit di tipo monetario, con cifre che mediamente vanno da 1500 a 1650 euro pro capite. Spesso questo tipo di benefit sono funzionali soprattutto all’attraction, ma risultano meno efficaci se utilizzati da soli come elemento di engagement e retention dei lavoratori. Solo il restante 10% viene allocato su interventi finalizzati a benessere fisico, psicologico e relazionale, flessibilità e work-life balance, sviluppo ed employability: quelli, cioè, considerati importanti dai lavoratori.
Il mismatch
Eccolo, dunque, emergere il mismatch tra offerta e domanda di corporate wellbeing, che genera una spesa inutile per le aziende e un’insoddisfazione crescente nei collaboratori: basti pensare che solo il 9% dei lavoratori sta bene su tutte e tre le dimensioni del benessere aziendale (soddisfazione, coinvolgimento affettivo nei confronti dell’organizzazione ed engagement). Al contrario, nelle organizzazioni che si occupano del benessere dei loro dipendenti, la percentuale di persone pienamente ingaggiate al lavoro, che mediamente si assesta al 19%, sale al 54%. Ma non solo: la percentuale di “felici al lavoro”, sale dal 5% al 23%.
“La relazione fra azienda e lavoratore sta vivendo un momento critico – spiega Mariano Corso, Responsabile scientifico dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano –. Le aziende fanno sempre più fatica a trovare, motivare e trattenere le persone, ma continuano a adottare approcci tradizionali per affrontare questa sfida. I lavoratori si sentono sempre meno ingaggiati e segnalano un aumento di situazioni di malessere. Le organizzazioni devono adottare un approccio organico e strutturato al tema del benessere, in grado di rispondere ai reali bisogni delle persone. Per massimizzare i risultati delle iniziative di corporate wellbeing non serve investire di più, ma meglio, attraverso una strategia unica e integrata, evitando di disperdere energie e lanciare comunicazioni contraddittorie alle persone”.
Un approccio sistemico
Ciò che serve, concorda Francesca Rizzi, AD di JOINTLY – è “un approccio sistemico, in cui il corporate wellbeing non è più ‘cosa si fa’, ovvero un insieme di iniziative, ma è il risultato di una people strategy finalizzata a un’esperienza lavorativa in cui le persone si sentano abilitate e supportate nel realizzare il proprio purpose all’interno e a servizio dell’organizzazione”.
Dai dati raccolti emerge, infine, che solo 1 azienda su 3 ha effettivamente integrato le iniziative di corporate wellbeing nella strategia aziendale e, di queste, solamente la metà stabilisce obiettivi e KPI per definirne il successo. Un altro 40% non ha addirittura nessuno strumento che consenta di monitorare l’impatto e quindi poter dimostrare se un’iniziativa è stata efficace o meno. A oggi, dunque, le aziende investono nel benessere dei dipendenti, ma in maniera non strutturata e quindi poco efficace: i dati evidenziano la mancanza di un approccio organico e strutturato al tema, in grado di rispondere ai reali bisogni delle persone.
Risulta quindi necessario – conclude la ricerca – passare da un sistema composto da servizi frammentati, con investimenti incentrati soprattutto sulla parte monetaria, a un approccio sistemico e integrato alle altre funzioni aziendali, supportato da una comunicazione chiara, efficace e tempestiva dei benefit e delle iniziative attuate.
Per approfondire: Malessere psicologico e work life-balance: ecco perché gli investimenti non bastano
Il malessere dal punto di vista psicologico presenta ricadute importanti anche per l’organizzazione aziendale. La ricerca condotta dall’Osservatorio HR del Polimi e da JOINTLY evidenzia come il 32% delle persone si sia assentato almeno una volta dal lavoro nell’ultimo anno per motivi di stress o ansia. Ma la tutela del benessere mentale rimane ancora in secondo piano: solo il 40% delle organizzazioni si impegna a creare ambienti di lavoro “sicuri” dal punto di vista psicologico. A incidere è anche il tema del work-life balance: la percentuale di coloro che hanno un buon grado di flessibilità ed equilibrio vita privata e vita lavorativa si attesta al di sotto del 20% e chi presenta una situazione più svantaggiata sono, ancora una volta, le donne. Nello specifico, solo il 40% delle aziende prevede un’estensione del congedo parentale retribuito della seconda figura genitoriale e circa il 30% servizi di supporto alla genitorialità, come l’asilo nido aziendale, o servizi di supporto ai carichi di cura verso famigliari fragili, come iniziative di assistenza a familiari anziani o con disabilità.

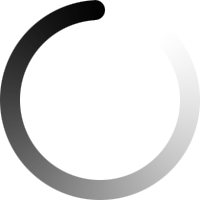
Comments are closed